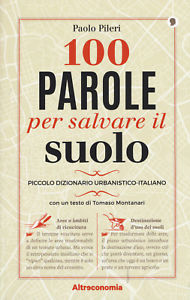 di Luca Garosi
di Luca Garosi
«Che vuol ch’io faccia del suo latinorum?» è la famosa frase che Renzo Tramaglino dice a Don Abbondio, quando il curato tenta di convincerlo che ci sono degli impedimenti al matrimonio del giovane con Lucia Mondella. Mi è ritornata in mente questa celebre parte dei Promessi Sposi leggendo l’ultimo libro di Paolo Pileri: “100 parole per salvare il suolo” edito dalla casa editrice Altreconomia.
Per l’autore la lingua dell’urbanistica è diventata una “lingua straniera”, non solo ma ha ben 8mila dialetti, tanti quanti sono i Comuni d’Italia. In Italia ogni Regione ha la sua lingua definita dalla propria legge urbanistica. Al di sotto delle Regioni poi ci sono i Comuni, ognuno con il proprio piano. Si è creata una separazione – spiega Pileri – tra chi amministra localmente e chi è amministrato. Tra chi detiene le chiavi del lessico urbanistico e chi se ne disinteressa o non lo riesce a comprendere. Tra i due gruppi c’è incomunicabilità, perché non parlano la stessa lingua. Questo crea anche un altro problema: chi conosce la “lingua straniera”, se non è in buona fede, potrebbe anche avvantaggiarsi di questa conoscenza.
Un libro per tutti – Per questo c’è bisogno di un dizionario, quello che fa l’autore in questo libro è – infatti – un lavoro da interprete. Cerca di dare a tutti la chiave di conoscenza delle principali parole usate in urbanistica. “Nella parola “tutti” – scrive l’autore – sono compresi anche gli esperti, perché anche loro ormai faticano a muoversi tra le loro stesse parole truccate e corrotte o solo complicate e che potrebbero più felicemente sostituire con un linguaggio semplice”. Anche amministratori e politici – sottolinea Pileri – sono tra i destinatari di questo dizionario: hanno il diritto e il dovere di capire le parole che possono far bene al suolo da quelle che lo possono, invece, danneggiare.

Cos’è il suolo? – «Iniziamo con un colpo di scena: il suolo non è lo stesso suolo in ogni Regione italiana», scrive Pileri e riporta una tabella dove ci sono i riferimenti normativi per il suolo e per la sua definizione suddivisi per Regione. In Italia – spiega ancora – abbiamo vissuto per anni (fino al 2014) con una definizione sbagliata di suolo, che non è stata cancellata ma integrata con la legge 152/2006, art. 5 – da una nuova parte che la migliora. Senza – però – renderla ottimale, sottolinea Pileri. Perché mancano due cose importantissime: il riconoscimento del suolo come risorsa ecosistemica e il riconoscimento che il suolo è una risorsa non rinnovabile, scarsa, vulnerabile e strategica per la sovranità nazionale.
Una prefazione ‘artistica’ – Una delle tante cose che mi ha fatto piacere leggere in questo libro è la sua prefazione. In quattro pagine, Tomaso Montanari, uno dei migliori storici dell’arte contemporanei, riesce a introdurre perfettamente il lettore al libro che sta per leggere. Non deve sembrare strano che per introdurre un testo del genere sia stato scelto uno storico dell’arte. Perché – come scrive Montanari – questa disciplina è quella che ha provato a tenere vivi i legami con il suolo. La storia dell’arte italiana a un certo punto ha avuto una “frattura felice”, spiega ancora Montanari, grazie a uno dei più alti testi della nostra tradizione artistica. Quel testo, scrive lo storico dell’arte, è l’articolo 9 della Costituzione italiana. Al secondo comma, l’articolo 9 dice che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Entra nella Costituzione l’idea dello ius soli, il diritto del suolo, espressione che Pileri usa spesso nel libro. Siamo nazione per via del suolo (non per via del sangue). Se uno cerca il suolo nella Costituzione – spiega Montanari – lo trova proprio nel paesaggio dell’articolo 9. Siamo cittadini se conosciamo il paesaggio e il patrimonio. E soprattutto tuteliamo e rispettiamo il suolo.

La grafica arricchisce i contenuti – Quando leggo un libro mi concentro molto sul suo aspetto grafico. “100 parole per salvare il suolo” colpisce anche per il suo aspetto: tre colori si alternano e si integrano. Il bianco delle pagine, il nero della maggior parte dei testi, il rosso di alcuni titoli e di tutti gli elementi grafici. Con un asterisco (rosso) si indicano le date importanti; una mano con un dito che indica introduce tutte le definizioni e tutti gli approfondimenti sono accompagnati da un apposito segno grafico; mentre le sigle, le leggi e altri riferimenti sono tra parentesi quadre.
L’autore – Appena ho finito di leggere il libro ho sentito il bisogno di approfondire la conoscenza di Paolo Pileri e sono andato a fare qualche ricerca su Internet. La sua competenza esce già prepotentemente dalle pagine del libro, ma andando a ‘googlare’ ho scoperto molte cose interessanti su di lui. Spero di riuscire a intervistarlo e a scrivere ancora di lui in questo blog.
